
Montepulciano d'Abruzzo DOC
La viticoltura in Abruzzo, come del resto in tutta Italia, ha origini antiche. L’introduzione di tecniche di coltivazione dei vitigni nella regione risale all’età etrusca. Il Montepulciano d’Abruzzo è oggi uno dei vini più conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. Il suo nome deriva dall’omonimo vitigno da cui è ottenuto, che venne introdotto nella regione agli inizi del XIX secolo. Oggi la Doc Montepulciano d’Abruzzo viene prodotta dalle uve coltivate sui terreni collinari, situati a un’altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare, delle quattro province abruzzesi. La Doc Montepulciano d’Abruzzo è prodotta nelle tipologie Rosso (anche Riserva), Cerasuolo e Colline Teramane (anche Riserva).
Come
si consuma
Il Montepulciano d’Abruzzo Doc Rosso va servito in calici bordolesi
a 16-18 °C di temperatura. Si abbina bene a preparazioni abbastanza
strutturate come primi piatti con ragù di carne, carni rosse grigliate
e al forno, agnello alla griglia, pecora al caldaro, maiale in porchetta,
spezzatino di maiale, formaggi vari, minestre e cacciagione. Anche il
Cerasuolo va servito a circa 16-18 gradi in calici bordolesi, e si abbina
a brodetto pescarese, primi piatti della cucina locale, scamorza appassita,
pecorino fresco, minestre e mortadelline di Campotosto. Il Colline Teramane
infine deve essere servito in calici ballon a 16-18 °C. Si accompagna
bene a formaggi stagionati, salumi, cacciagione e carni rosse.
Come
si conserva
Per una corretta conservazione i vini Montepulciano d’Abruzzo Doc
devono essere tenuti in posizione orizzontale su scaffalature di legno,
o d’altro materiale resistente alle vibrazioni e lontano da fonti
di luce. Il locale di conservazione deve avere una temperatura costante
tra i 10 e i 15°C e umidità intorno al 70-75%, così
da non far asciugare i tappi.
Come si produce
Il metodo di produzione dei rossi di questa Doc prevede che la fermentazione
del mosto avvenga a contatto con la vinaccia che durante questa fase rilascia
parte delle sostanze in essa contenute, quali antociani e tannini. In
sostanza, l’uva viene pigiata e, nella maggioranza dei casi, diraspata,
quindi solfitata con aggiunta di anidride solforosa. A questo punto, negli
speciali recipienti vinari chiamati fermentini, inizia la fase di fermentazione
e macerazione, che ha una durata generalmente superiore ai 15 giorni.
Seguono la fase della svinatura, che permette la separazione delle bucce
e dei vinaccioli dal mosto-vino, i travasi, l’affinamento e l’invecchiamento.

Trebbiano d'Abruzzo DOC
L’etimologia del nome Trebbiano, non è facile da individuare, Plinio, nella sua "Storia Naturale", scrive di un "Trebulanum" originario della Campania che sarebbe poi stato importato in Abruzzo. Questo vino che durante il periodo dell’impero romano, godeva di scarso successo presso i bevitori raffinati, tanto da essere chiamato il vino dei soldati suoi grandi estimatori, è oggi uno dei più noti e apprezzati vini italiani. D’altro canto le terre d’Abruzzo, come ricordò anche il poeta latino Ovidio, originario di Sulmona, sono sempre state generose di uve e vini pregiati.
Come
si consuma
Il Trebbiano d’Abruzzo va servito ad una temperatura di circa 10°,
12° gradi in calici per vini bianchi giovani. Il periodo di consumo
ottimale è entro un anno dalla vendemmia. Si abbina bene a pesce,
piatti a base di uova, formaggi come l’incanestrato, scamorza e
minestra di farro.
Come si conserva
Per una corretta conservazione il Trebbiano d’Abruzzo Doc deve essere
mantenuto in posizione orizzontale su scaffalature di legno, o d’altro
materiale resistente alle vibrazioni e lontano da fonti di luce. Il locale
di conservazione deve avere una temperatura costante tra i 10 e i 15°
C e umidità intorno al 70-75%, così da non far asciugare
i tappi.
Come
si produce
La vinificazione del Trebbiano d’Abruzzo Doc, essendo un vino bianco,
è tecnicamente delicata. I vini bianchi, infatti, sono facilmente
soggetti ad alterazioni microbiche e fermentazioni anomale. Il processo
di vinificazione tende all’immediata estrazione del succo dal frutto,
in maniera che la fermentazione riguardi solo la parte liquida e non le
bucce. A tal fine, la pigiatura non sempre viene effettuata, per evitare
maltrattamenti della materia prima, e spesso viene operata la pressatura
su uve intere che serve, in sostanza, per separare il mosto dalle parti
solide, riducendo al minimo la lacerazione delle bucce. Alla pressatura
seguono la sfecciatura del mosto, che consiste nell’allontanamento
delle particelle in sospensione o fecce, la solfitazione con anidride
solforosa e la fermentazione che non deve superare i 20 °C. Al termine
avviene la svinatura con i travasi che ne consentono l’illimpidimento.
Ultimati i travasi, il prodotto è pronto per l’imbottigliamento

Rientra nella grande famiglia delle Malvasie, conosciute come vitigni tra i più antichi; presente in Italia da millenni e con presunta origine greca. Tra le diverse Malvasie, questa è sicuramente presente in Abruzzo dal secolo scorso.
Caratteristiche
viticole
Vitigno
a bacca bianca; foglia medio-grande; grappolo grande, lungo, alato; acino
medio-piccolo, rotondo con buccia trasparente; media vigoria.
Caratteristiche
enologiche
Vino
dal colore giallo paglierino, sapore e aroma caratteristico, mediamente
spiccato.

Vitigno sicuramente appartenente alla grande famiglia dei Moscati. Questo biotipo è presente da lungo tempo nell'areale omonimo chietino ed è stato oggetto di vinificazioni anche differenziate, per esempio per produrre spumante.
Caratteristiche
viticole
Vitigno
a bacca bianca; foglia di media dimensione; grappolo medio-piccolo, piramidale,
abbastanza serrato; acino sferoidale, di medio-piccola dimensione.
Caratteristiche
enologiche
Vino
con caratteristiche tipiche dei moscati (Catalano), ma non molto spiccate.
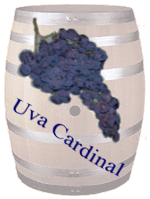
Pare che i terreni di questa zona siano i più vocati sia alla qualità sia alla precocità di questa varietà, che, a chi non è giovanissimo, ricorda una ghiottoneria delle vacanze: fino a non molti lustri fa sulle spiagge adriatiche, invece degli immigrati nordafricani con accendini e altri ammennicoli, passavano tra gli ombrelloni i venditori di canditi.
In realtà non erano canditi veri e propri ma lunghi spiedini di legno infilati in varia frutta incrostata e impregnata di zucchero.
Tra i vari tipi di frutta di stagione, i più gettonati erano i pezzi di limone con la buccia e, appunto, gli acini di cardinal: sgranocchiati insieme erano indimenticabili. E infatti sono un ricordo indelebile.

Vitigno di probabile origine spagnola; presente in diverse areali dell'ltalia centrale tra cui in Toscana fin dall'ottocento; la sua diffusione risulta limitata a piccole zone indifferenziate e, nel complesso, a produzioni globali contenute nelle zone dell' Italia centrale.
Caratteristiche
viticole:
foglia grande; grappolo grande o medio-grande di forma allungata conico-cilindrico;
bacca blu-nera, medio grande, con buccia spessa; vitigno molto vigoroso.
Caratteristiche enologiche:
il vino è spesso molto colorato, rosso rubino brillante. aroma
fruttato, contenuto alcolico medio-elevato, acidità medio-bassa.
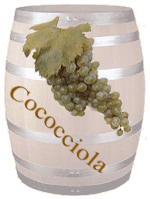
Vitigno autoctono abruzzese, coltivato soprattutto in provincia di Chieti nei territori dei comuni di Vacri, Ari e Rocca San Giovanni. Presente solo molto sporadicamente nel resto del territorio regionale. Viene utilizzato solo in uvaggio con altre uve, in particolare dei trebbiani.
Caratteristiche viticole:
vitigno a bacca bianca, rustico, mediamente vigoroso; foglia grande; grappolo
grande, spesso alato e irregolare, più o meno compatto; acino grande
rotondo o sub-rotondo, con buccia a volte giallastra oppure verdastra
a maturazione.
Caratteristiche enologiche:
il vino è di colore giallo paglierino scarico, presenta un'acidità
sostenuta che conserva bene nel tempo, aroma erbaceo; viene utilizzato
solo in uvaggio con altri vitigni , soprattutto con Trebbiano.